Nel mondo del non profit, ogni parola conta. Conta per chi legge, per chi dona, per chi si riconosce in una causa. Ma conta soprattutto per chi rischia di restare escluso: persone con disabilità cognitive, difficoltà linguistiche, un basso livello di alfabetizzazione o semplicemente una diversa familiarità con il linguaggio “formale” delle organizzazioni.
Il linguaggio accessibile è, prima di tutto, una forma concreta di inclusione: permette a più persone di comprendere, partecipare, sentirsi coinvolte. Se una storia è scritta in modo che tutti possano capirla, allora quella storia può diventare davvero collettiva, e la solidarietà che ne scaturisce più ampia e consapevole.
Per questo, scrivere per il non profit significa anche imparare a non dare nulla per scontato: non il significato delle parole, non la familiarità con certi temi, non il contesto di chi legge. Una comunicazione inclusiva parte dall’ascolto e si traduce in messaggi chiari, accessibili, empatici. Perché dietro ogni parola difficile o frase contorta, può nascondersi una porta chiusa.
Chi rischia di rimanere escluso
Un linguaggio complicato può diventare una barriera vera e propria per molte persone. Tra queste:
- Persone con dislessia, afasia o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
- Persone con autismo o con disabilità cognitive
- Chi ha una bassa scolarizzazione o poca dimestichezza con la lettura
- Migranti che stanno imparando l’italiano come seconda lingua (L2)
Quando la comunicazione è difficile da comprendere, si blocca la catena: comprensione → partecipazione → impatto. E se il messaggio non arriva, non genera azione. Il non profit ha il compito (e l’opportunità) di rendere le sue storie e le sue richieste accessibili anche per loro.
Cinque tecniche per uno storytelling accessibile
1 – Frasi brevi e strutturate
Una frase = un concetto. Evita periodi lunghi e complessi.
Esempio:
❌In considerazione delle numerose difficoltà socio-economiche emerse a seguito dell’emergenza sanitaria, abbiamo attivato un programma di supporto psicologico rivolto alle famiglie in situazione di fragilità.
✅ Durante la pandemia, molte famiglie hanno avuto difficoltà. Per questo, abbiamo attivato un aiuto psicologico per chi è in difficoltà.
2 – Lessico quotidiano e concreto
Usa parole comuni. Evita espressioni burocratiche, astratte, tecnicismi:
“Costruire una scuola” è più diretto di “implementare un progetto educativo infrastrutturale”.
3 – Ordine e ritmo visivo
Suddividi il testo in paragrafi brevi, usa titoli e sottotitoli, elenchi puntati o numerati, grassetti e spaziature.
Un testo ben strutturato accompagna il lettore, lo orienta, gli consente di fermarsi, tornare indietro, rileggere con facilità. In questo modo anche chi affronta la lettura con più difficoltà può sentirsi coinvolto.
Esempio pratico
Testo compatto:
| “Abbiamo attivato un programma di supporto alimentare nei quartieri più colpiti dalla crisi. Il progetto ha coinvolto volontari, partner locali e famiglie in difficoltà, raggiungendo oltre 500 nuclei familiari attraverso la distribuzione di pacchi viveri e buoni spesa settimanali per un periodo di tre mesi.” |
Testo accessibile e visivamente ordinato:
| “Il nostro programma di supporto alimentare Nei quartieri più colpiti dalla crisi abbiamo attivato un progetto per aiutare le famiglie in difficoltà. Cosa abbiamo fatto: Coinvolto volontari e partner localiDistribuito pacchi viveri e buoni spesaAiutato oltre 500 famiglie per tre mesi Ogni famiglia ha ricevuto un aiuto concreto, ogni settimana.” |
Il contenuto è lo stesso, ma l’organizzazione visiva rende il messaggio più chiaro, più immediato e più accessibile per tutti.
4 – Racconti personali, con nomi e dettagli reali
Le storie sono il cuore della comunicazione sociale. Ma per essere davvero accessibili, devono essere raccontate con parole semplici e concrete. Troppo spesso si scivola in formule retoriche, narrazioni astratte, o descrizioni generiche che non aiutano a entrare in relazione.
Un racconto personale ben costruito parte da 3 elementi essenziali:
- Un nome e un volto (reale o rappresentativo): permette di identificarsi o immedesimarsi.
- Una situazione concreta, non astratta: meglio “non potevo comprare i quaderni per i miei figli” che “vivevamo in una condizione di indigenza economica”
- Un cambiamento visibile: cosa è successo grazie all’intervento? Mostralo con un’immagine semplice, anche quotidiana.
Esempio:
Mi chiamo Amina, ho 11 anni. Quando è arrivata la guerra, ho dovuto lasciare la scuola. Oggi, grazie al progetto, ho un quaderno nuovo e posso tornare a scrivere. In poche righe, il lettore scopre chi è Amina, cosa le è successo, e qual è l’impatto del progetto. Nessuna parola difficile. Nessuna frase superflua. Solo la forza di una storia vera, raccontata con chiarezza e rispetto.
5 – Leggi ad alta voce
Se il testo “suona bene” ad alta voce, probabilmente è accessibile anche a chi ha difficoltà di lettura. Se inciampi, rileggi o ti perdi: semplifica.
Lo storytelling visivo aiuta a capire
Non sempre le parole bastano. Anche le immagini aiutano a rendere un messaggio più accessibile: foto, icone, disegni, simboli, se scelti con cura e coerenza, possono rinforzare il significato del testo, guidare l’attenzione e aiutare a comprendere anche chi ha difficoltà linguistiche o cognitive.
Per raccontare un progetto agricolo in Africa, un’immagine di una donna che semina, una piccola infografica con pochi dati visivi e una mappa semplificata possono dire molto più di un testo lungo e descrittivo.
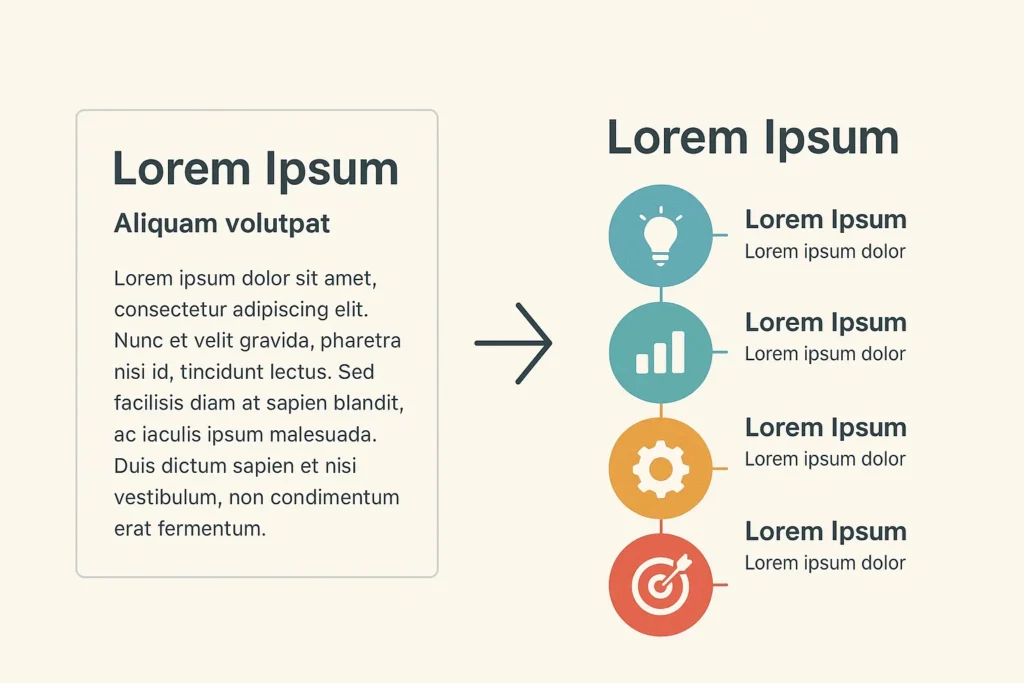
Facile da leggere, facile da capire
In Europa esistono linee guida precise per la scrittura in linguaggio “facile da leggere e da capire” (Easy-to-read), pensato in particolare per le persone con disabilità intellettive. Questi standard sono stati sviluppati da Inclusion Europe, la federazione europea delle organizzazioni di persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie, con l’obiettivo di rendere l’informazione davvero accessibile a tutti.
Le linee guida Easy-to-read seguono regole stringenti su:
- struttura del testo
- scelta delle parole
- uso di immagini e simboli di supporto
Anche se non sempre integralmente applicabili nel fundraising, questi principi rappresentano una risorsa preziosa per rendere la comunicazione più chiara e inclusiva, soprattutto per chi ha difficoltà di comprensione.
Un documento, una brochure o una pagina web scritti in linguaggio facile possono diventare veri strumenti di partecipazione, anche per chi normalmente si trova ai margini della comunicazione.”
Comunicare per includere
Rendere accessibili le storie del nostro lavoro, quelle che raccontano vulnerabilità, resilienza, speranza significa permettere a tutti di comprenderle, sentirle, farle proprie. Significa costruire una comunicazione che unisce, non che seleziona. E nel farlo, non perdiamo nulla in profondità. Guadagniamo in efficacia, umanità e impatto. Perché la solidarietà comincia anche da qui: dalle parole che scegliamo ogni giorno.
a cura di Serena Basilicata – Account Manager







